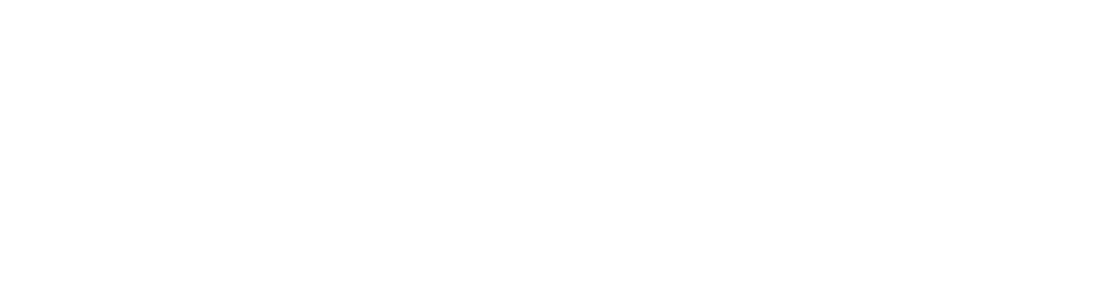Untitled, un invito gentile a registi e artisti visivi a misurarsi con la propria creatività in un tempo che non ha nome né traccia.
La scelta del concept dell’edizione 2020, come potete immaginare, non era semplice. Come tutti voi, anche noi ci sentiamo fragili, disorientati e tremanti. Non nutriamo certezze né siamo in grado di delineare orizzonti futuri o di dare un nome alle cose. Sostiamo qui, come voi, come tanti, alternando umori, visioni e spostando le tende per sbirciare fuori. Con il rigore dell’umiltà, vi proponiamo una call “UNTITLED”: un invito gentile a registi e artisti visivi a misurarsi con la propria creatività in un tempo che non ha nome né traccia.
Sin dagli esordi dell’aggressione virale del COVID-19, ciò che più prepotentemente ha investito le nostre esistenze e le ha rese sgomente è stato dover apprendere che la scienza è imprecisa e approssimativa ed è ostile al bisogno illimitato di conforto di noi esseri umani. Tutti noi, in queste settimane in cui l’evento pandemico ha travolto e sospeso tempo privato e tempo collettivo, abbiamo cercato nella scienza la certezza del lieto fine, improvvisandoci esperti lettori di grafici, tabelle e curve ascensionali nel tentativo di placare ciò che per definizione non può essere placato: la paura della morte, nostra e dei nostri cari. Tuttavia, anche chi non ama la poetica del “realismo sporco” di Bukowski, converrà che «un uomo con la testa nel forno acceso e i piedi nel congelatore statisticamente ha una temperatura media». E, quindi, che fare?
Molti di noi, operatori culturali o artisti, me compresa, hanno cercato tana e consolazione nella bellezza e nell’arte. Ma la visione pixellata e offesa dal taglio di una tapparella che si riflette sul monitor che riflette a sua volta una tela di Vermeer o l’interpretazione traballante di una poesia di Giorgio Caproni attraverso un altro schermo, al di là del mio schermo, al di là del mio balcone, si è presto ammantata di una malinconia feroce. E, badate, non per l’ovvia nostalgia di non poter essere davanti a quel dipinto, al rosso che si accende nel marrone, né per l’assenza di pubblico intorno, ma perché credo non dovremmo avere bisogno singolarmente e tutti insieme di questo rito scacciaguai.
L’arte come la scienza si muove oltre il conforto. E, come la scienza, è un’eredità che viene da lontano, che si muove qui, nell’oggi, di cui abbiamo traccia genetica: i nostri sistemi immunitari si sono adattati ai virus, la musica ha creato interi sistemi neuronali. Nessuna frattura o rivoluzione epistemologica, tuttavia, né in campo scientifico né in campo artistico, è mai stata in grado di farci accettare la morte. Nello struggente grapich novel La terra dei figli di Gipi, due fratelli si trovano soli in uno scenario post-desertificazione brutale e senza norme e sarà la carezza di una madre a far accettare la Fine del mondo fino ad allora conosciuto, a far accettare che «dopo la fine nessun libro venne più scritto».
Tanta filmografia, tanta letteratura e tanto teatro ci hanno regalato, negli ultimi decenni, visioni immaginifiche, distopiche e post-apocalittiche. E, pur prestando il fianco ad accuse di snobismo e citazionismo, noi la desolazione di Uomini e topi di Steinbeck qui ve la vogliamo ricordare, tutta tutta fin dove ad evocarla comincia il dolore, perché senza la voce dei padri non si avvera sutura nelle storie dei figli, perché senza l’inchino ai maestri non sarebbe possibile l’audacia del sorpasso.
Non cerchiamo risposte, non cerchiamo guarigione precoce dal trauma, non cerchiamo racconti di questo tempo, per ciò che sta accadendo. Non vi chiediamo di raccontare l’oggi. Ciò che vogliamo sono visioni artistiche che esercitino, nel loro dire, perplessità e intelligenza, umanità e disorientamento, nudità e coraggio, vulnerabilità e immaginazione. Vi chiediamo di mostrarci il vostro fuoco, perché forse ce la caveremo o forse no. Noi mica lo sappiamo. Se né la scienza né l’arte possono consolarci dalla morte, però, il fuoco ci offre conforto da sempre, assieme alle parole dei padri e alle carezze delle madri. Attorno ai falò, fin dai tempi degli orsi e dei lupi, qualcuno ha sempre cominciato a raccontare una storia, qualcuno ha sempre osato un graffito, qualcun altro ha sempre intonato una nenia. E finché ci sarà qualcuno a caricarsi sulle spalle una cinepresa e a dire «ciak, si gira», avremo fuoco a sufficienza per scorgere l’altro in viso, ombre sui muri per profetizzare il cinema a venire, calore abbastanza per placare la morsa del gelo per gli abbracci che oggi non possiamo dare e ricevere.
Sarebbe stato possibile davvero un altro titolo per questo tempo senza abbracci?
Annalisa Zito
direttrice della Fondazione Pasquale Battista